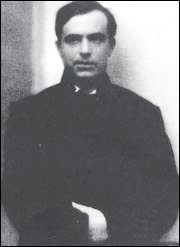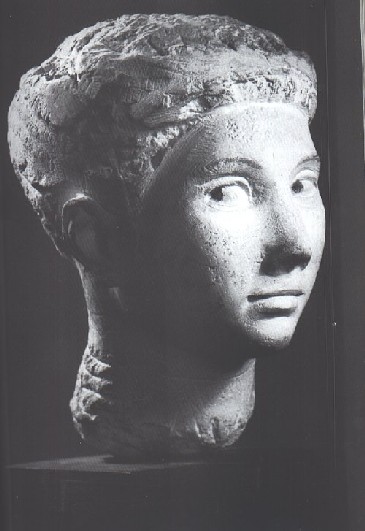Figlio di artigiani,
pratica per qualche tempo la ceramica e frequenta la scuola professionale. Alla
svolta del secolo è iscritto alla Scuola libera del nudo all'Accademia di
Firenze; frequenta assiduamente i musei e lo studio di De Carolis - col quale
collaborerà anche per breve tempo - e stringe amicizia con Soffici e Costetti.
Nel 1901 ottiene il secondo premio al Concorso Alinari e collabora con
xilografie e disegni al "Leonardo" di Papini e all"'Hermes"
di Borgese.
Compiuto il servizio militare nel 1903-05, ritorna a Firenze e
concorre al Pensionato artistico nazionale,nel 1909, risultandone vincitore.
Frattanto, nel 1908, sposa Pasqualina Cervone, conosciuta alla scuola di
Fattori, e con lei si trasferisce a Roma nel 1910. I primi anni romani sono
segnati da difficoltà anche di carattere economico.
Dopo una prima mostra al
Pensionato artistico (1912) partecipa alle mostre della Secessione nel 1913 e
nel 1915, ottenendo i primi successi. Richiamato alle armi, nel 1917 è
riformato a causa del manifestarsi dei primi sintomi della nefrite cronica che
causerà la sua prematura scomparsa. Si trasferisce con la moglie e i figli in
una villetta ai Parioli, allora ai margini della campagna romana, che diverrà
meta di assidue frequentazioni dei suoi amici letterati e artisti, Cecchi, Baldini, Cardarelli, Papini, Soffici, Ungaretti, Oppo, de
Chirico, Bartoli. Espone nel 1918 nella mostra d'Arte Italiana a Zurigo, quindi si presenta con
un'ampia personale alla Casina del Pincio.
L'amicizia con Cecchi e Baldini, la
frequentazione del milieu culturale della "terza saletta" del Caffè
Aragno contribuiscono ad avvicinarlo, nel 1919, alla "Ronda",
e anche il gruppo di "Valori
Plastici" si interessa al suo lavoro, pur tra polemiche e difficoltà.
Nel 1920, grazie all'interessamento di Ojetti, che gli dedica quell'anno una breve monografia, vince una cattedra a Firenze, ma
rinuncia per non allontanarsi da Roma e il Comune gli dà in affitto uno studio
all'Uccelliera a Villa Borghese.
Il crescente interesse intorno alla sua pittura
lo solleva dalle difficoltà economiche, mentre le condizioni di salute
incominciano a peggiorare. Lo stesso anno è nominato accademico di S. Luca e
dall'anno successivo fa parte del comitato per le Biennali romane (1921-'25. Nel
1922, presentato da Savinio,
espone alla Fiorentina primaverile con il gruppo di "Valori
Plastici". Nel 1923 partecipa all'esposizione di arte italiana a Buenos
Aires. Nel 1924 ha una sala personale alla XIV Biennale di Venezia, che lo
consacra fra gli artisti ormai affermati, ed è presente alla "Carnegie
Exhibition" di Pittsburgh; collabora alla rivista di Soffici
"Galleria"; Oppo, Baldini, Cecchi e Soffici gli dedicano una monografia.
Anche dopo la morte, l'opera di Spadini
rimane il termine di paragone imprescindibile per le giovani generazioni romane,
fino alla grande mostra, organizzata da P.M. Bardi nel 1930, alla Galleria
di Roma appena inaugurata. Sino al 1910 circa, l'opera di Spadini passa
attraverso influenze dei macchiaioli e dei preraffaelliti. Negli anni delle
Secessioni ha una svolta in senso "impressionista", che l'artista più
tardi rinnegherà in parte, ma che conferisce al suo lavoro quella
caratteristica componente cromatica e luminosa.
Tale rinnovamento dopo la guerra
risentirà anche di attenti studi sulla pittura antica. Nel 1983 si tenne a
Roma, presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, una grande mostra
antologica del pittore Armando Spadini per ricordarne il centenario della
nascita.
Questa mostra, come ricordò opportunatamente Fortunato Bellonzi, rese
giustizia ad un protagonista dell’arte nostra tra il 1915 e il 1924, l’anno
in cui si rivelò, quasi alla vigilia della morte, con la personale nella XIV
Biennale di Venezia dove espose cinquanta dipinti. Spadini era nato a Firenze
nel 1883; la madre era di Poggio a Caiano. Avendo iniziato come uno degli ultimi
“macchiaioli” toscani, Spadini rappresenta il più delicato punto di
contatto con l’impressionismo francese, nell’accogliere con originalità la
grande lezione di Renoir.
All’Accademia di Belle Arti, dove si iscrive alla
prima classe di pittura lo stesso anno di Ardengo Soffici, Giovanni Costetti e
Oscar Ghiglia, conosce Giovanni Fattori. Nel 1910 vinse un pensionato a Roma e
da allora cominciò la sua tipica pittura di studi all’aria aperta, nella
fervida atmosfera di Villa Borghese, dalla quale traeva spunto anche per i suoi
quadri di maggior impegno, dove il soggetto comune aveva talvolta un titolo
leggermente ironico come nel “Mosè salvato dalle acque”. Ebbe inizio allora
un periodo fervido di opere, raramente esposte, mentre il pittore viveva in una
difficile situazione economica.
La sua prima personale fu quella alla Casina
Valadier di Roma e l’ultima, lui vivente, ebbe luogo alla Biennale del 1924.
Fu aiutato da alcuni collezionisti, tra cui l’avvocato Emanuele Fiano di Roma.
L’iter di Spadini si svolse rapido e deciso.
Considerandosi, nonostante il suo
tirocinio a una scuola professionale un vero e proprio allievo di Fattori che
insegnava all’Accademia, l’artista non dimenticò l’impressione icastica,
il segno forte e conclusivo del suo maestro ideale. Da Fattori imparò a
guardarsi dalla retorica liberty e pseudomichelangiolesca, anche quando da
giovane fu chiamato da De Carolis, che insegnava decorazione a Firenze, poiché
lo aiutasse nei lavori di decorazione a Bologna.
La morte precoce raggiunse
l’artista prima di una vera affermazione; la sua importanza nell’arte
italiana fu compresa soltanto più tardi, quando il successo della Biennale del
1924 gettò una luce più chiara su un’opera che da allora crebbe di continuo,
imitata e studiata, comunque feconda di provvide influenze per il suo amore alla
vita, per la sua splendida pienezza.
Adolfo Venturi nella sua monografia del
1927 così si espresse: “Dire di Armando Spadini, della sua arte che è un
canto alla grazia infantile, alla intimità familiare, alla luce e al colore, a
tutto ciò che parla al nostro cuore e ride ai nostri occhi, è compito grato,
riposo dell’anima”.
Morì a Roma nel 1925. Le sue spoglie riposano nel
cimitero di Poggio a Caiano. Ed è proprio questo Comune, così caro a Spadini,
che ha voluto ricordarlo nel 1995, a settant’anni dalla sua scomparsa, con una
bella mostra retrospettiva allestita nella splendida Villa Medicea del Sangallo.
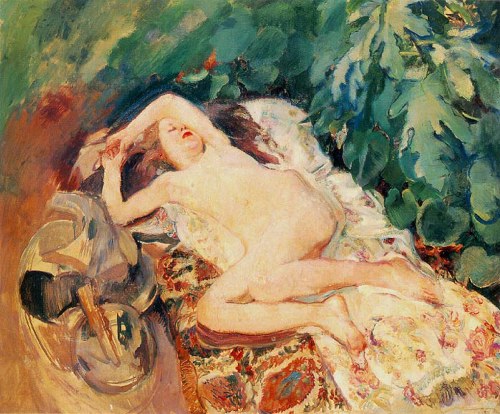
Armida
|
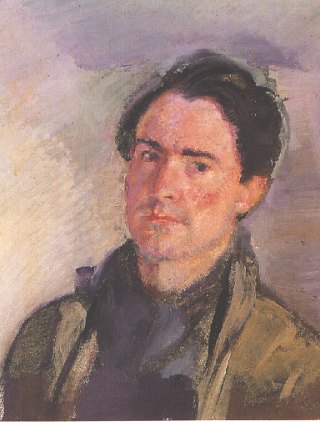
Titolo: Autoritratto,1917
Dimensioni: cm. 54,5x44
Tecnica: olio su tela

Ritratto della moglie
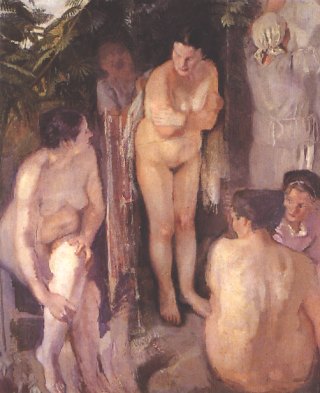
Titolo: Gruppo di bagnanti, 1923
Dimensioni: cm. 129x108
Tecnica: olio su tela

Gruppo di famiglia

Confidenze

Bimbo in culla
torna su - up |
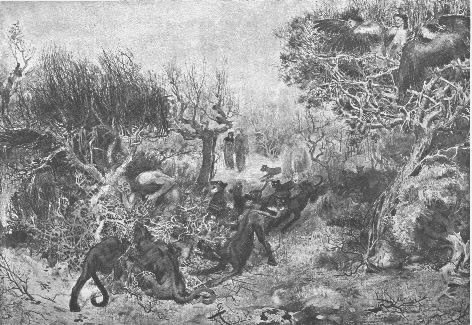
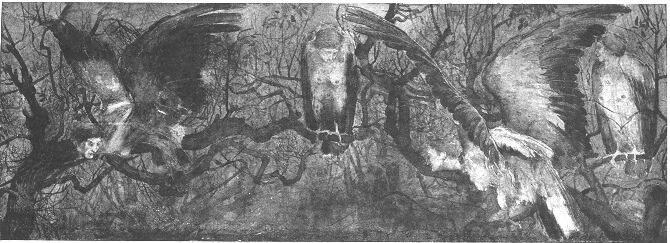 ____
____